Tags
Related Posts
Share This
elogio dell’imperfezione dei corpi
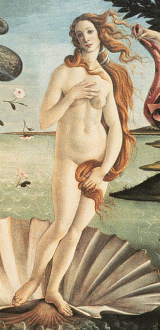 Ero in spiaggia, e guardavo i corpi delle persone.
Ero in spiaggia, e guardavo i corpi delle persone.
I corpi giovani sono pieni, torniti, fluidi, come se non avessero linee di frattura nella continuità del loro contorno.
Facevo una gara tra me e me, senza premio e soprattutto senza giudice terzo, cercando di capire solo guardandone le fattezze quale fosse l’età della persona che di volta in volta mi si muoveva vicino.
E ho scoperto che più che le forme in sé – che pure sono enormemente indicative, quasi una specie di carbonio 14 – è il movimento, piuttosto, a dare la misura dell’età.
E’ la sicurezza di sé, è il modo che si ha di prendere possesso dello spazio con il proprio corpo a indicare con migliore approssimazione l’età della vita che si sta vivendo.
Questa forma di possesso dello spazio è come se seguisse una parabola il cui apice raramente coincide con il momento del massimo splendore delle proprie forme.
Come se per essere più sicuri di sé, insomma, bisognasse attraversare almeno un pochino la paura del decadimento, affrontare un po’ della sensazione della sfioritura.
Una ragazzina o un ragazzino non hanno consapevolezza della propria femminilità o della propria mascolinità; e spesso mettono in scena una specie di finzione, di parossismo di genere.
Le femmine inseguono un modello di perfezione formale nel quale mai riusciranno a entrare, eppure sono costantemente impegnate a provarci, a crederci, come se l’esperienza della corporeità e della sensualità non potesse che incistarsi in un corpo perfetto.
Così, si vedono tristissime ragazzine disperatamente consapevoli della loro battaglia persa (non sanno che la guerra è lunga, e possono benissimo vincerla loro), e ragazzine sovreccitate già aggressivamente soddisfatte della loro appetibilità (ma tragicamente attrezzate a essere e a rappresentarsi solo come un oggetto di proprietà altrui).
E i maschi tentano l’impossibile scalata alla vetta della virilità incontaminata, quella che mortifica, umilia e possiede le femmine solo con uno sguardo, oppure – anche qui – camminano curvi, malinconicamente consapevoli del fatto che per loro, almeno al momento, non c’è storia.
Ma né gli uni né le altre possono avere la benché minima idea di cosa effettivamente possa significare scendere a patti con la propria identità di genere, scoprirsi femminili oppure maschili.
Questo tipo di consapevolezza di sé discende dall’esperienza che di sé si è fatta, lungo percorsi accidentati che sono contemporaneamente dolorosi e gioiosi; e ha bisogno di tutto il tempo che serve per fare la fatica di staccarsi dai modelli e di riavvicinarsi, semmai, agli archetipi.
La scoperta – e l’utilizzo – della dimensione sensuale prescinde dalla perfezione del proprio corpo o del corpo altrui, insomma.
Lo misuravo, in spiaggia, osservando quanta preoccupazione seduttiva e sensuale riesca ancora a promanare da corpi stanchi, sfioriti, usurati.
Che spesso però riescono a esprimere una misteriosa armonia meglio dei corpi giovani e floridi.
Tra il dentro e il fuori di sé c’è un infinito gioco di rimandi, e una parte – nell’alterna fortuna di un dinamismo mai stabilizzato – tenta di assecondare l’altra, di conformarsi all’altra.
In una parola, di meritarla.
Un ragazzino non si è ancora meritato.
Bisognerebbe che i genitori lo dicessero, ai loro figli: adesso godete della vostra perfezione (sia che siate ragazzi o ragazze fieri di voi, o al contrario preoccupati della vostra scarsa attrattività) e appropriatevene; ma ricordate che il vostro corpo vi dirà molte più cose belle – carnalmente belle, e non letterariamente belle oppure moralmente consolatorie – quando sarà imperfetto.
E questo non è moralismo.






 Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.
Ho scritto il noir
Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.
Ho scritto il noir 


mah! io so solo che oggi ho visto le foto di flavia vento sul corriere in costume e mi sono quasi sentita una gran gnocca:>
Senti, già t’ho detto della tua somiglianza con la Ferilli. Ora non ti mettere a fare la modesta, eh?
Comunque anch’io mi sono consolata, a vedere la Vento.
Va detto…
Solo che queste in tre settimane di trattamenti gggiusti tornano come nuove, Ollie!
Noi no.
😉
macche’ nuove e nuove!
scusa ma tu quanti soldi investi settimanalmente dall’estetista?
io quei 30€ ogni 2/3 mesi per farmi una ceretta….
se ci andassimo noi con la stessa frequenza delle televisive, allora sai che sgnacchere ;>
Era proprio quel che dicevo! Che loro spendono patrimoni!
Io – comunque – spendo ancora meno di te, dall’estetista.
Le ultime quarantamila lire le ho spese nel 1998.
Poi, stop.
(Sarà perché sono bella dentro, credo)
Da ometto rispondo che se hai la fortuna di incontrare una gran Donna qualche segno del tempo la fa solo diventare più reale, viva, intensa.
Un seno pieno ed un cervello vuoto o un cuore arido non sono segni di gran femminilità. Il primo lo riempi artificialmente ma per gli altri due o provvede natura o non ci son santi…
Non l’ho detto ma mi sembrava implicito: condivido completamete il tuo post!
Vale – credo – anche per gli uomini.
Ma la cosa strana è che sembra che, su se stessi, gli uomini non siano in grado di dire niente.
Quando si tratta dei loro corpi, sono improvvisamente ridotti all’afasia, e non riescono ad articolare nessun pensiero.
Delle loro pance e del loro sformarsi non parlano. Semplicemente, non esiste.
Gli unici corpi rilevanti, l’unica bellezza che conta – vera o finta, non importa – è quella femminile.
Dei maschi, tutti – e loro per primi – tacciono…
Non è curioso?
Certo che vale anche per noi! Ma mantengo la speranza che almeno voi, nei nostri confronti, siate più intelligenti di quanto noi in media lo siamo nei vostri.
Per quello che mi riguarda ho sempre considerato intelligenza calore e profondità doti essenziali in una donna anzi, non mi voglio prendere nessun merito, non è nemmeno questione di scelta ragionata, mi sono reso conto, col passar del tempo, che riuscivo a provare un reale interesse solo per donne che avessero anche queste caratteristiche.
C’è chi preferisce i soprammobili, e chi le persone.
P.S. tanto per ripondere anche alla “provocazione” del tuo replay: ho superato la quarantina da qualche anno e combatto con una pancetta che tenta di ripresentarsi dopo che sono riuscito due anni fa, e dopo vent’anni di convivenza, a “quasi sconfiggere”.
Giusto per toglierti qualche speranza di troppo, Andrea: no, noi non siamo affatto più intelligenti di voi.
Cioè: chi sì e chi no, intendo. Ma non è che siccome siamo donne siamo più intelligenti. Purtroppo siamo imbecilli uguale.