i «mangiatori di dolore»
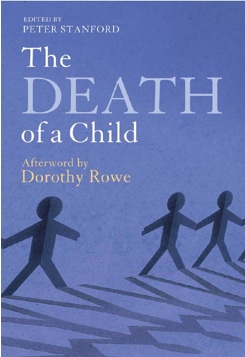 Sull’Irish Times di oggi c’è un pezzo in cui la scrittrice Catherine Dunne racconta di quando, vent’anni fa, perse il figlio Eoin.
Sull’Irish Times di oggi c’è un pezzo in cui la scrittrice Catherine Dunne racconta di quando, vent’anni fa, perse il figlio Eoin.
Il pezzo, splendido, è confluito in «The Death of a Child», una raccolta di saggi in cui dodici scrittori si misurano con la perdita di un figlio o di un fratello. L’antologia, edita da Continuum, è uscita da pochi giorni e costa 23 euro.
Quella che segue è la mia traduzione del testo (non integrale: nel libro è più lungo) apparso sul’IT.
Se ci sono errori è solo ed esclusivamente colpa mia, e ne chiedo scusa.
SONO le sei meno dieci della mattina del 28 febbraio 1991. Le mie doglie si interrompono e il mio piccolo fa il suo ingresso nel mondo scivolandoci dentro silenziosamente. Troppo silenziosamente.
Apprendo che la Guerra del Golfo è finita. Sembra che a essere finita sia anche un’altra battaglia, qui.
LA mia ostetrica Caitriona avvolge Eoin nelle lenzuola verdi dell’ospedale e me lo porge. «È bello», mi dice.
Lo prendo, lo stringo a me, sorpresa di quanto tepore il suo corpo emani. Ma sì, naturalmente: ha solo pochi minuti. Il freddo arriverà più tardi.
GLI carezzo il volto. «Povero topolino», dico.
***
LA nostra veglia durò tutta la notte. C’erano il mio medico, Patricia; Caitrìona; altre ostetriche i cui nomi ho dimenticato, e mio marito.
Ognuno di noi, a turno, piangeva, rideva, raccontava storie e storielle, entrando e uscendo dalla sofferenza. Era una di quelle occasioni in cui il significato profondo delle cose sembra nascondersi dietro gli oggetti più comuni: dietro una tazzina, per esempio.
UN distacco della placenta, mi disse Patricia. Non ne avevo mai sentito parlare. È quando la placenta si separa dalle pareti dell’utero.
«Abruption», si dice in inglese. Ed è esattamente così che avviene: ex abrupto, all’improvviso. Il bambino, minuscolo astronauta, precipita al di fuori del suo mondo protetto e autosufficiente, volteggiando verso un’atmosfera dove c’è un altro tipo di gravità.
NON ha sofferto, mi garantì Patricia. Per lui è stato come mettersi a nanna.
«PERCHÈ io? Perché noi?», mi domandavo in silenzio.
Quando arrivò, la risposta fu un «e perché no?».
***
DUE giorni dopo, siamo fuori a fare spese. Eamonn ha appena comprato un regalo per il fratellino. Prende per Eoin un oggetto simile alla coperta azzurra, ciò che nella sua vita di bambino tiene più a cuore. La compriamo, la impacchettiamo, ci dirigiamo verso casa. Mi sento piena di meraviglia per il coraggio di questo bambino di otto anni.
«VOGLIO prendergli la mano», aveva detto dopo che gli avevamo spiegato quel che era successo. Sembrava solido, determinato. Le infermiere lo osservavano mentre scartava la copertina goffrata verde, prendeva fra le sue le dita fredde del fratello.
SE ne andarono in silenzio, tornando poco dopo con bibite, biscotti e un piatto di dolcetti lievitati ricoperti di glassa azzurra e Smarties.
***
LA gente mi diceva che mi ci sarebbe voluto del tempo. E ce ne volle, ma non nel senso che intendevano loro. Le giornate persero ogni nitidezza, sfumando ovattate nelle notti. Le settimane collassavano l’una dentro l’altra, svuotate, come oggetti fiacchi e senza forma. Mi lavavo, mi vestivo, facevo le pulizie, guidavo, stiravo, dirigevo i lavori di casa, piangevo.
L’UNICA cosa che non facevo era guardare la valigia aperta sul pavimento della mia stanza da letto; guardare tutti quei pacchetti pieni di promesse, che non avevo avuto modo di portare con me all’ospedale, così da potermeli lasciare alle spalle.
CAMICIOLE, tutine, pannolini.
***
IN quei primissimi giorni, mi affanno nel tentativo di capire il motivo per cui, vedendomi, persone precedentemente cordiali passano dall’altra parte della strada; perché la conversazione è levigata e fragile come vetro; perché le persone si tengono a distanza da questa morte come se i suoi frammenti avessero il potere di farle sanguinare. Mi affanno per cercare di capire come replicare a quelli che mi dicono che ho «un angelo in paradiso», o che di bambino ne avrò un altro: come se i bambini, le persone, fossero sostituibili.
E MENTRE mi faccio faticosamente largo lungo il sentiero di quelle prime settimane, sono sopraffatta dal desiderio che si renda visibile un segno: qualcosa che mostri al mondo che io sono una madre devastata dal suo lutto. Mi vengono in mente le pietre nere cucite nella manica di mio padre quando morì la nonna. Mi viene in mente come la gente chinava la testa al suo passaggio in segno di saluto, gli stringeva la mano, gli toccava il gomito. In quei piccoli segni di riconoscimento della sua perdita, estranei e vicini, senza distinzione, gli offrivano consolazione.
QUESTO mi manca; o perlomeno qualcosa del genere.
***
IN lingua Urdu c’è un modo di dire che amo: «ghum-khaur». Significa «mangiatori di dolore», e identifica la comunità che si raccoglie intorno a chi vive un lutto, per assorbirne lo strazio. In quella lingua non ci sono parole per definire un dolore vissuto in solitudine; manca l’idea stessa della privatezza della perdita.
IL mio primo «mangiatore di dolore» è stato un uomo di nome John O’Donoghue. È un «tanatologo», uno – insomma – che della morte e del morire si occupa per motivi di studio. Parlò a una conferenza sette settimane dopo la nascita di Eoin e fu provocatorio, vigoroso e persuasivo. Si scagliò energicamente contro l’idea che il dolore si potesse semplicemente rimuovere.
ASCOLTANDOLO, percepii la prima scintilla: il ritorno alla vita era possibile. Non semplicemente l’accettazione o la capacità di scendere a patti con gli eventi, ma la possibilità di un reinvestimento pieno e incondizionato nella vita e nella vitalità.
***
BASTA poco tempo; e capisco cosa significa essere una famiglia, cosa significa avere amici. Capisco cosa posso chiedere all’una e agli altri durante il mio lungo, lento ritorno. Apprendo, anche, che la parabola del dolore non si muove secondo una tempistica standardizzata, che non ci sono tappe obbligate che possano essere nitidamente contrassegnate da un segno di spunta: là ci sono stata, questo è stato fatto. È un processo. Una cosa che si muove come la marea; che un giorno ti toglie la terra da sotto i piedi e il giorno dopo ti sostiene e ti consola.
***
QUANDO si tratta di dolore, vengono generalmente presi per buoni alcuni luoghi comuni. Persone gentili volevano farmi sapere che i primi sei mesi sono i peggiori, che poi le cose sarebbero state più facili. Dopo il primo anno, vedrai, ci sarà la svolta. Comincerai a sentirti meglio.
BEH. Sì, ma anche no. Se davvero esisteva una cosa simile a una progressione automatica e lineare verso il ritorno alla vita, allora cosa poteva spiegare, in prima fila alla conferenza di O’Donoghue, la presenza di tutte quelle persone avanti negli anni?
PIU’ che settantenni, confessavano che non erano mai riusciti a venire a patti con la morte dei loro figli. La società aveva accolto il loro lutto ammutolendosi nel rifiuto di dire l’indicibile.
NON avevano l’attrezzatura, dicevano; non avevano conoscenza, comprensione, sostegno. E così erano stati consumati per decenni dalla loro personale privata tristezza. Per loro non c’era stato nessun «mangiatore di dolore» Non c’era stato alcun riconoscimento del fatto che il loro era un dolore che domandava di essere visto, condiviso, ammorbidito dalla possibilità di parlarne e dall’incontro con la tenerezza di qualcuno. Il ritorno alla vita era rimasto al di là di loro, per sempre al di fuori della loro portata.
MI colpì molto la comprensione di quanto il rituale sia cruciale per il ritorno alla vita. In sua mancanza, restiamo privi di un punto di partenza, di decollo, di separazione tra il passato e il futuro. Rimaniamo sospesi per aria, tra le ombre, incapaci di tornare indietro, e senza alcuna volontà di andare avanti.
SIAMO programmati per il dolore, sembra. È la nostra reazione alla forza dei legami che ci tengono uniti. È un processo emotivo confuso e complesso, quello del «riassorbimento» della perdita e del ritorno alla vita. Con un bambino morto alla nascita, manca un passato da rimpiangere con legittimo strazio – cosa che in se stessa rappresenta un’ulteriore perdita – ma resta comunque la necessità di fare pace con tutte le infinite possibilità future che non ci sarà mai consentito di concretizzare.
E C’È un dato di fatto ancora più pesante da guardare in faccia. Benché padri e madri siano straziati dalla perdita di un figlio che è figlio per entrambi, in realtà essi provano ciascuno, separatamente, il proprio dolore.
ALCUNI sostengono che nelle relazioni occorre prendere piena coscienza di una differenza fondamentale: che per le madri un bambino è – anche se gli altri non la percepiscono – un’enorme presenza materiale lungo tutto l’arco di tempo in cui la gravidanza procede. Per i padri, spesso la materialità si rende chiara solo al momento della nascita. C’è una disconnessione, una deviazione della percezione; uno sguardo differente sulla perdita.
PER entrambi è devastante, ma per ciascuno è differente.
***
IL conforto del rituale; la compagnia dei «mangiatori di dolore»; l’apprendimento del modo in cui si possa vivere momento per momento; l’acquisizione della consapevolezza del potere delle parole dette e scritte: tutto questo mi ha accompagnato nell’attraversare quel passaggio.
Tracciare un diagramma delle fasi del ritorno alla vita è difficile esattamente come pretendere di vivere il proprio dolore progressivamente, un poco alla volta.
MA mettere in conto quattro anni è una congettura che, sì, va bene come qualunque altra. A me, in quel momento il dolore smise di tendere imboscate. Si spostò su un registro differente e acquistò una nuova tonalità. Alla fine prese a crescere il forte sentimento di essere stata risparmiata dalla sorte. Era accompagnato dalla marea nera del senso di colpa: com’era potuto accadere che fossi io, e non mio figlio, la persona che era sopravvissuta? Ma a poco a poco, negli anni immediatamente successivi, divenne via via prevalente un’altra percezione: quella che mi era stata concessa un’altra possibilità.
COMINCIAI a percepire la vita come un dono, in senso letterale.
***
COMINCIAI a scrivere come un’indemoniata. Il senso di vuoto a pcoo a poco venne meno. Riuscivo a concentrarmi di nuovo, a dormire di nuovo, a rallegrarmi di nuovo per la nascita dei bambini degli altri. Il mondo non mi si mostrava più in bianco e nero. Era animato da colori più soffusi, da sfumature di luce che mettevano in ombra il buio. I germogli del ritorno alla vita che una volta avevo intravvisto stavano diventando piante robuste; ancora a rischio di congelamento – sì – ma, nonostante tutto, profondamente radicate nel futuro.
E SCRIVERE mi ha rimesso al mondo.
***
EOIN è ancora parte della mia vita quotidiana. Anche se non è più quella luce accecante che, giusto al centro della mia fronte, oscura qualunque altra cosa, Eoin resta accanto a me. Una presenza delicata, una guida esigente. Eoin mi ha insegnato che il dolore è, più che ogni altra cosa, un senso di separazione così drastico e acuto che perfino ora, a vent’anni di distanza, io riesco a rimettermi in contatto con quella sensazione senza la più piccola difficoltà, benché sia tutt’altro che un’emozione di poco conto.
***
SE avrei voluto che le cose fossero andate diversamente? Ma certo. Starebbe per compiere vent’anni, adesso, e spesso me l’immagino a tavola con me. Io gli riservo le sue decorazioni personali sul mio albero di Natale, e un posto solo per lui dovunque io mi trovi.
MA è un posto che è in armonia con il resto della mia vita.
***
JOHN O’Donoghue paragonava i primi giorni del dolore a un’enorme fotografia collocata in casa, un’immagine del bambino morto che troneggia sulla mensola del camino, alle pareti della stanza, nelle vite di chiunque condivida quello spazio. A poco a poco, l’immagine ha bisogno di ridimensionarsi; è ancora là dove stava prima, ma non è più dominante.
C’È VOLUTO del tempo: tempo che non è più stato rubato, ma utilizzato: allo scopo di guadagnare un punto d’appoggio nel girone infernale del dolore.
ORA, Eoin ha la misura di una foto da passaporto, così posso portarlo con me dovunque io vada. Il mio compagno di viaggio, mio figlio, il mio maestro.
NON posso evitare di domandarmi come sarebbe il suo aspetto.
Quando mi capita di domandarmelo, mi basta guardare suo fratello.
E sorrido.
(Ognuno, penso, si porta dietro la sua immensa fotografia di qualcosa o di qualcuno, che a poco a poco rimpicciolisce).







 Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.
Ho scritto il noir
Scrittrice e giornalista, ho lavorato per oltre vent'anni nei quotidiani, dimettendomi in agosto 2012 da un contratto a tempo indeterminato.
Ho scritto il noir 


è il dolore di molti, di tanti, di troppi, nn abbiamo ancora un dio ke ci spieghi il xkè, mi piacerebbe ascolatre la sua difesa
È la vita, forse?
Che commozione, leggere la mia storia dopo 11 anni. Parola per parola, è stato ed è così. “Il mio compagno di viaggio, mio figlio, il mio maestro”: quanto è vero.
Grazie. La tua traduzione è stupenda. Il mio Stefano ora avrebbe 22 anni. Questo racconto mi ha fatto rivivere 22 anni di vita… e d’amore.
Grazie a te, Irma. E a te, Claudia. E a te, Angie.
E a tutte e tutti voi che avete letto o leggerete questa cosa, o il libro intero.
ciao Lorenzo, amore mio piccolo che non ho avuto il coraggio di guardare, di stringere fra le mie braccia, terrorizzata dal fatto che ti avrei ricordato così, privo di vita, addormentato per sempre…
e grazie Federica…
Ciao, Monica.
Non dire grazie.
Ognuno ha la sua fotografia gigante.
Magari non è un figlio, e magari è vivo: ma quella foto gigante è lì che si fa lentamente più piccola e a tratti giganteggia di nuovo.
La società aveva accolto il loro lutto ammutolendosi nel rifiuto di dire l’indicibile.
E anche ammutolendoli, vorrei aggiungere…perché oggi nessuno vuole più sentire parlare di dolore, vedere il dolore… negandolo si cerca di negarne l’esistenza. E negare la morte. Vieni lasciato solo. Nel tuo dolore. Ti chiedono di non esprimerlo, di non farlo vedere, di non mostrarlo. Pena l’ostracismo sociale. Quando più ne avresti bisogno.